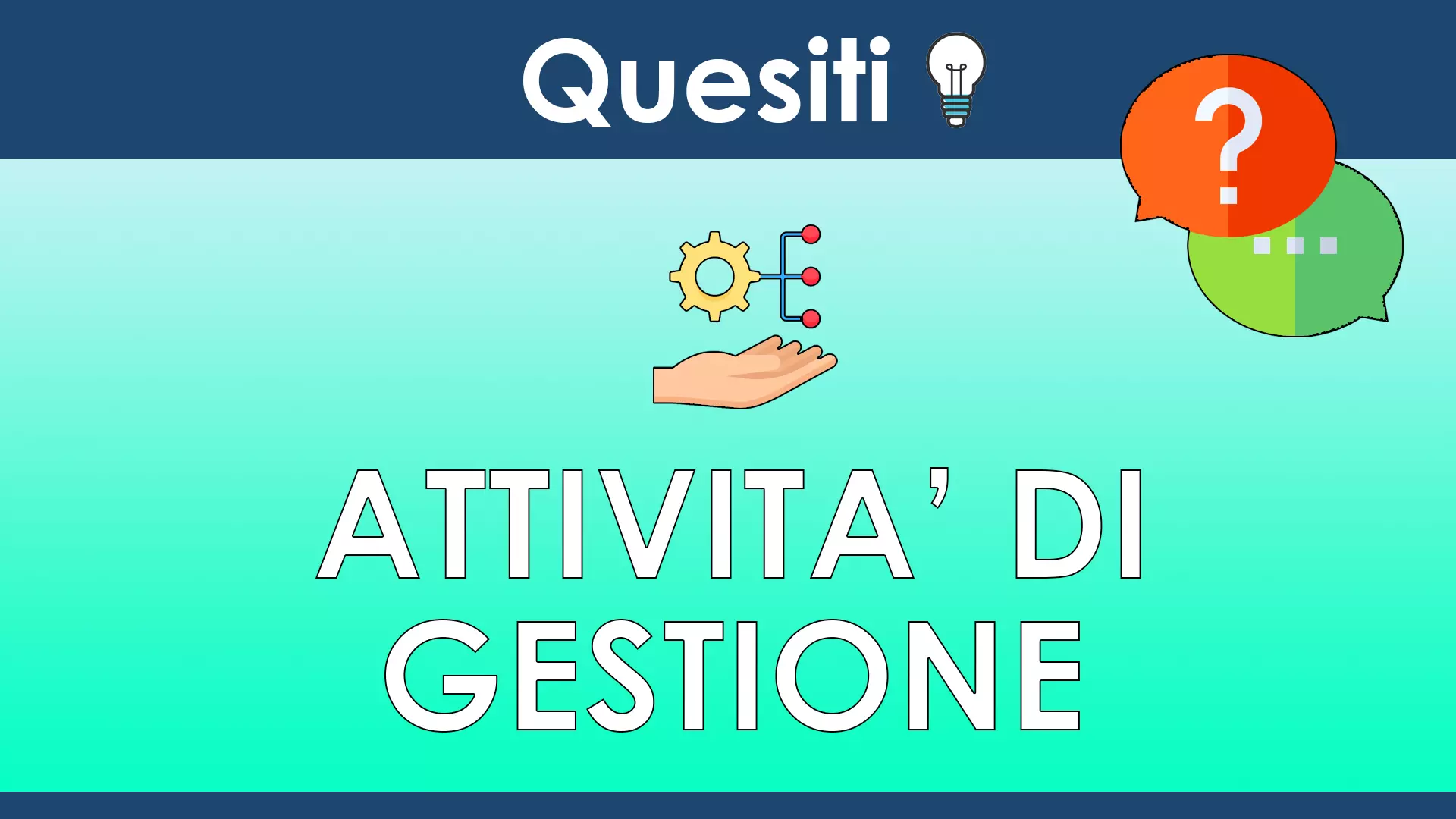di Gianluca Dradi, Avvocato e Dirigente Scolastico
Commento a Cass. sent. n. 2334 del 31.01.2018
Il caso
Una studentessa all'ultimo anno di un istituto secondario superiore di Bari, riportava lesioni a seguito di una caduta, al momento dell'uscita dalla palestra dell'istituto, conseguente all'accalcamento ed alle spinte da parte dei compagni di scuola.In primo grado il Tribunale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire il danno, mentre la Corte d'Appello, con sentenza n. 371 del 6.05.2013, negava la responsabilità dell'istituto e dell'insegnante, ritenendo che la responsabilità gravasse sulla danneggiata stessa e sui suoi compagni di classe, tutti maggiorenni.
Affermava inoltre che l'art. 2048, comma 2 codice civile, riguarda solamente i fatti illeciti commessi da minorenni.La danneggiata presentava ricorso per la cassazione della sentenza e la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo all'erronea interpretazione dell'art. 2048, comma 2, ritenendo la norma applicabile anche nel caso di studenti maggiorenni.
La questione giuridica
Come ormai noto, la responsabilità della scuola per i danni subiti dall'allievo, si inquadra come responsabilità di tipo contrattuale nel caso di danni che lo studente procuri a sé stesso, mentre come responsabilità extracontrattuale nel caso di danni che lo studente arrechi ad altri soggetti.In entrambi i casi il danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento è tenuto a dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto durante il periodo in cui lo studente era affidato alla scuola. Spetta invece al debitore della prestazione risarcitoria (il personale scolastico) dimostrare l'assenza di responsabilità: nel primo caso trova applicazione l'art. 1218 C.C., e quindi l'onere di provare che l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo – accessoria a quella di istruire ed educare- deriva “da causa a lui non imputabile”. Nel secondo caso trova applicazione l’art. 2048, commi 2 e 3, e quindi la scuola deve provare “di non aver potuto impedire il fatto”.
Al di là delle diversa terminologia usata dal legislatore, in entrambi i casi si assiste ad un’inversione dell’onere della prova dell’elemento soggettivo (la colpa) della responsabilità, spettando sempre al soggetto tenuto alla vigilanza il compito di dimostrare il caso fortuito, cioè l’evento imprevedibile o inevitabile che esclude la colpa.La prova liberatoria si sostanzia nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il fatto, che nondimeno si è verificato per la sua imprevedibilità o inevitabilità.
La questione giuridica che si vuole qui affrontare attiene però ad un altro aspetto: se il principio di presunzione di colpa previsto dall’art. 2048, con conseguente aggravamento di responsabilità degli insegnanti, si estenda o meno al fatto degli studenti maggiorenni.La questione è controversa ed appare utile rammentare l’origine storica della norma, la quale era già presente nel precedente codice civile del 1865. L’accostamento dei genitori ai precettori è espressione di una concezione in cui l’insegnante, oltre ad istruire ad una scienza o ad un’arte, svolge una funzione educatrice volta alla formazione della personalità degli allievi: “il precettore delle famiglie benestanti e il maestro d’arte delle botteghe artigiane avevano sugli allievi e apprendisti un’autorità derivata e simile a quella del padre. In questa prospettiva la loro responsabilità per l’illecito commesso dal minore è apparsa come il naturale completamento della responsabilità dei genitori”.
L’attuale formulazione letterale dell’art. 2048 c.c., solo a proposito dei genitori puntualizza che la responsabilità si applica fino a che il soggetto è minorenne. Tuttavia la norma dovrebbe essere oggetto di una valutazione unitaria, posto che il secondo comma introduce una forma di responsabilità che deriva da quella dei genitori. Infatti la responsabilità degli insegnanti interviene quando non c’è la vigilanza dei genitori, in conseguenza del fatto che l’allievo viene affidato alla scuola.
Inoltre, così come il requisito della convivenza, previsto nel primo comma, costituisce il presupposto della responsabilità dei genitori, quello del “tempo di vigilanza” (normalmente l’orario delle attività scolastiche) rappresenta la condizione di possibilità per l’esercizio dell’attività di cura e protezione. Addebitare agli insegnanti il danno cagionato da allievi maggiorenni, significherebbe rendere la loro posizione più gravosa rispetto a quella dei genitori.Il fatto poi che il terzo comma dell’art. 2048 c.c. non differenzi la prova liberatoria tra genitori e precettori depone a favore dell’ipotesi che entrambi i soggetti siano tenuti a doveri non dissimili, seppure diversamente dilatati nel tempo e con distinta intensità.
Questa è, ad oggi, la posizione prevalente in dottrina, recepita anche in diverse pronunce giurisprudenziali, si veda – ad esempio- Cass. sent. n. 7387/2001: “ la presunzione di colpa di cui all’art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile nel caso in cui l’allievo sia persona maggiore di età, dovendosi presumere che, all’interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d’arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante”.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ribalta l’interpretazione, finora prevalente, della norma. Ritiene, infatti, che le due tipologie di responsabilità contenute nell’art. 2048 non rappresentino due species di un unico genus, il cui discrimine sarebbe la maggiore età dell'autore del fatto illecito. L'ontologica diversità tra le due ipotesi emergerebbe, invece, proprio dalla mera lettura dei due commi:il primo disciplina la responsabilità per culpa in educando, senza peraltro indicare che cosa genitori e tutori abbiano omesso di fare affinché la responsabilità insorga, secondo un principio di responsabilità totalizzante. Il secondo, che disciplina la culpa in vigilando, indica invece espressamente ciò che non sarebbe stato fatto, ovvero la vigilanza.
Sebbene la «vigilanza» costituisca un onere che grava anche sui genitori dei figli minorenni,quella prevista dal secondo comma è di contenuto specifico, “in quanto si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro allievi e apprendisti”: con ciò viene escluso che il mero raggiungimento della maggiore età estingua l'onere di vigilanza, poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo e quindi “sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento/addestramento”.
La maggiore età come presunzione di caso fortuito
A compensazione di questo irrigidimento interpretativo, la Suprema Corte evidenzia però che il raggiungimento della maggiore età non è circostanza priva di effetto: se non serve ad escludere, sic et simpliciter, la responsabilità presunta dei docenti, incide però sull’onere probatorio che incombe su questi ultimi, allegerendolo.
Infatti, dopo aver richiamato le numerose pronunce che adeguano l’intensità della vigilanza all’età del vigilato, nel senso che il contenuto dell’obbligo è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, “con la conseguenza che con l’avvicinarsi di costoro all’età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza” (Cass. sent. 369/1980 e, in maniera simile, Cass. 12424/1998, Cass. 2272/2005, Cass. 11453/2003, Cass. 22752/2013), la Corte rammenta che la prevedibilità dell’evento dannoso rappresenta l’elemento dal quale nasce la necessità della vigilanza, la quale si commisura al grado di esistenza di una carenza di autosufficienza dei soggetti nella gestione della propria condotta.
Ma il legislatore, conferendo la maggiore età, presume una capacità di autogestione dei soggetti. Pertanto l'età maggiorenne incide sul contenuto dell'onere probatorio dell'insegnante, in quanto “la dimostrazione, da parte sua, della maggiore età dell'allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l'evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale condotta”.
Al dunque, quindi, la nuova interpretazione della norma conduce pur sempre – nella generalità dei casi (non così, però, se il maggiorenne aveva manifestato elementi di asocialità o se è persona notoriamente ostile/vendicativa) – ad un’assenza di responsabilità aggravata per il fatto illecito degli allievi maggiorenni[2].
Costituiscono tuttavia, sempre secondo la Corte, un’eccezione al principio di presunzione della capacità di autonomo discernimento del maggiorenne, quelle attività tecniche (attività sportive, artigianali, meccaniche) che costituiscono oggetto di insegnamento, con conseguenti compiti di direzione e controllo tecnico e disciplinare, per le quali, pertanto, l’onere di vigilanza non può dirsi attenuato.