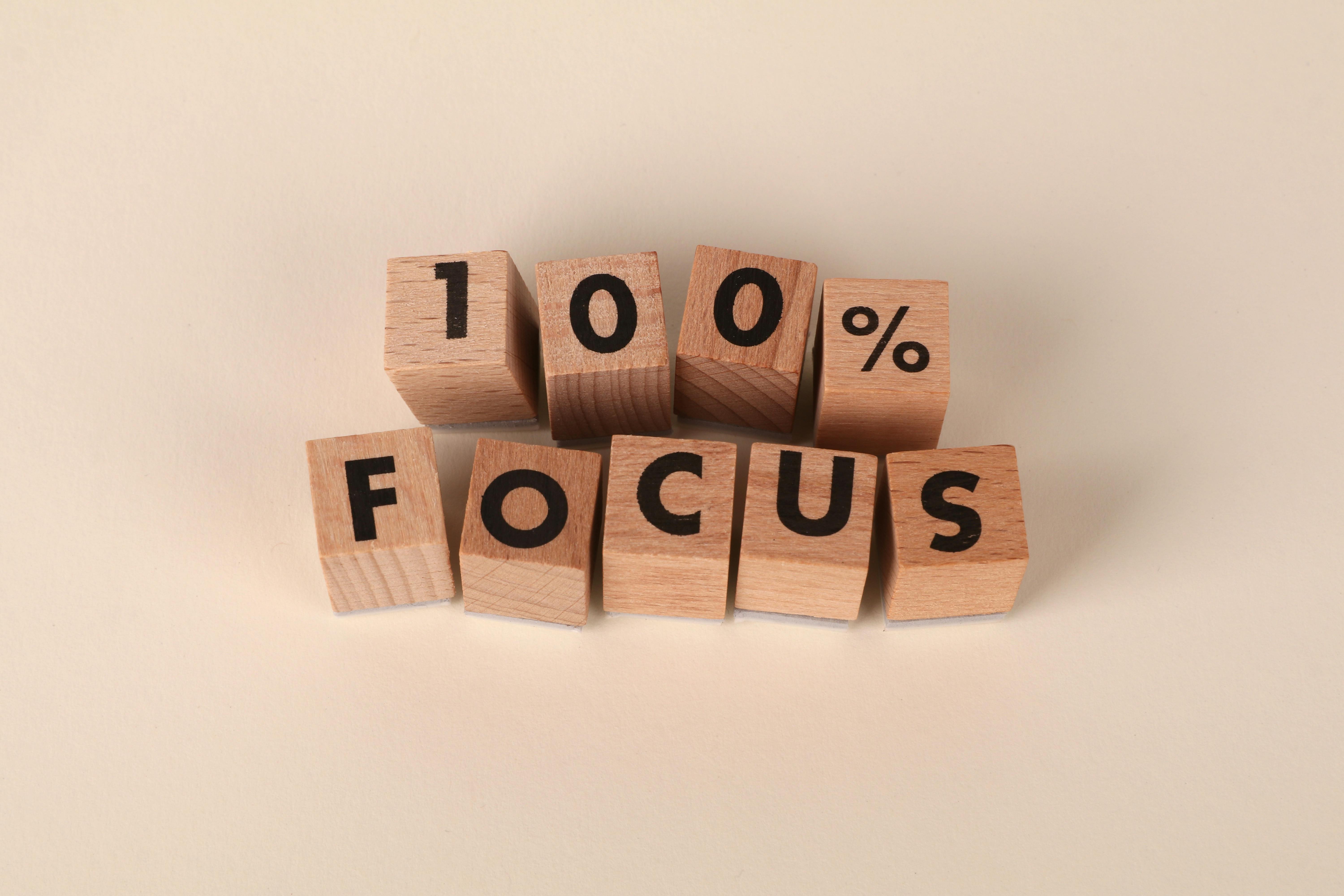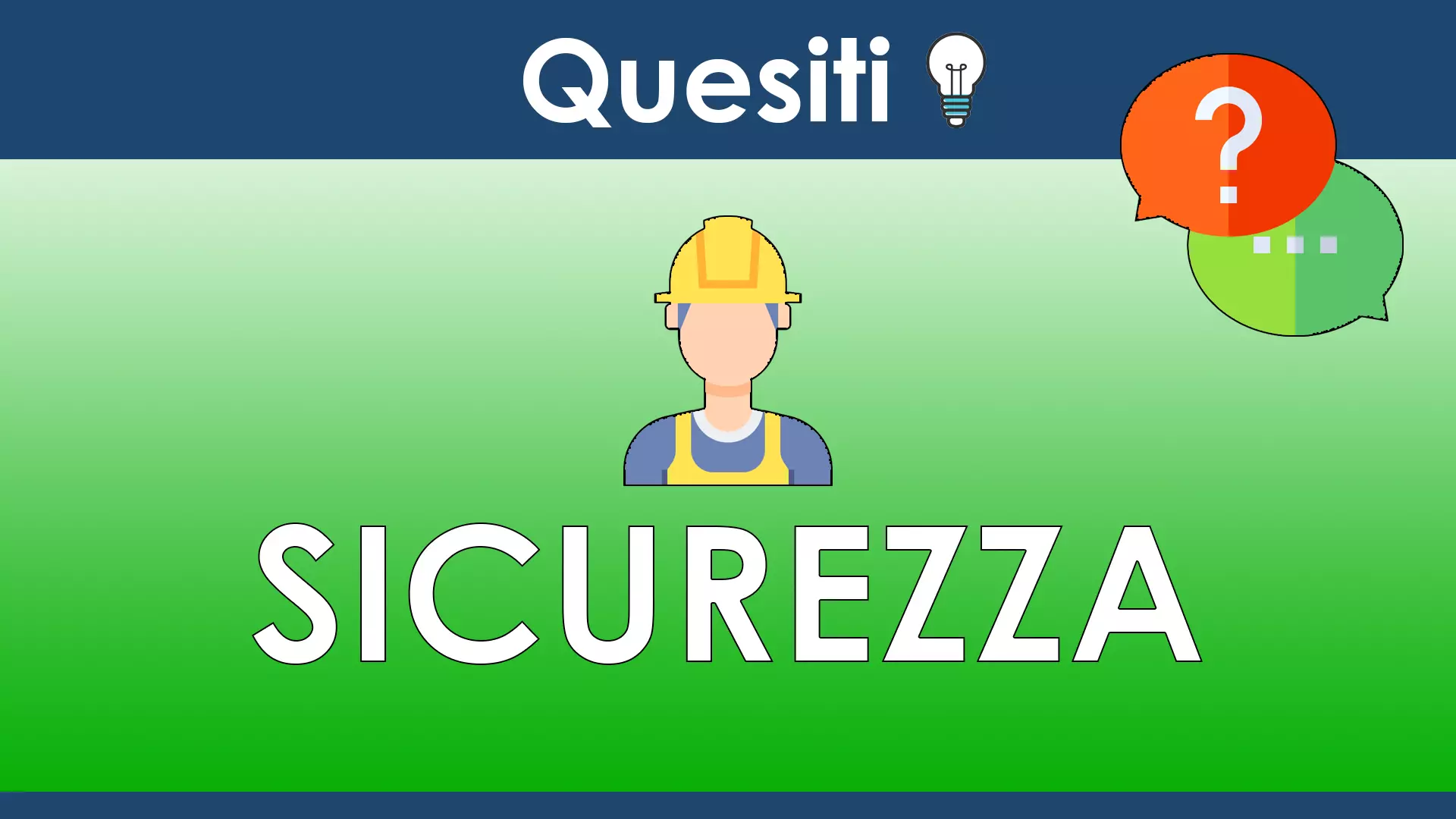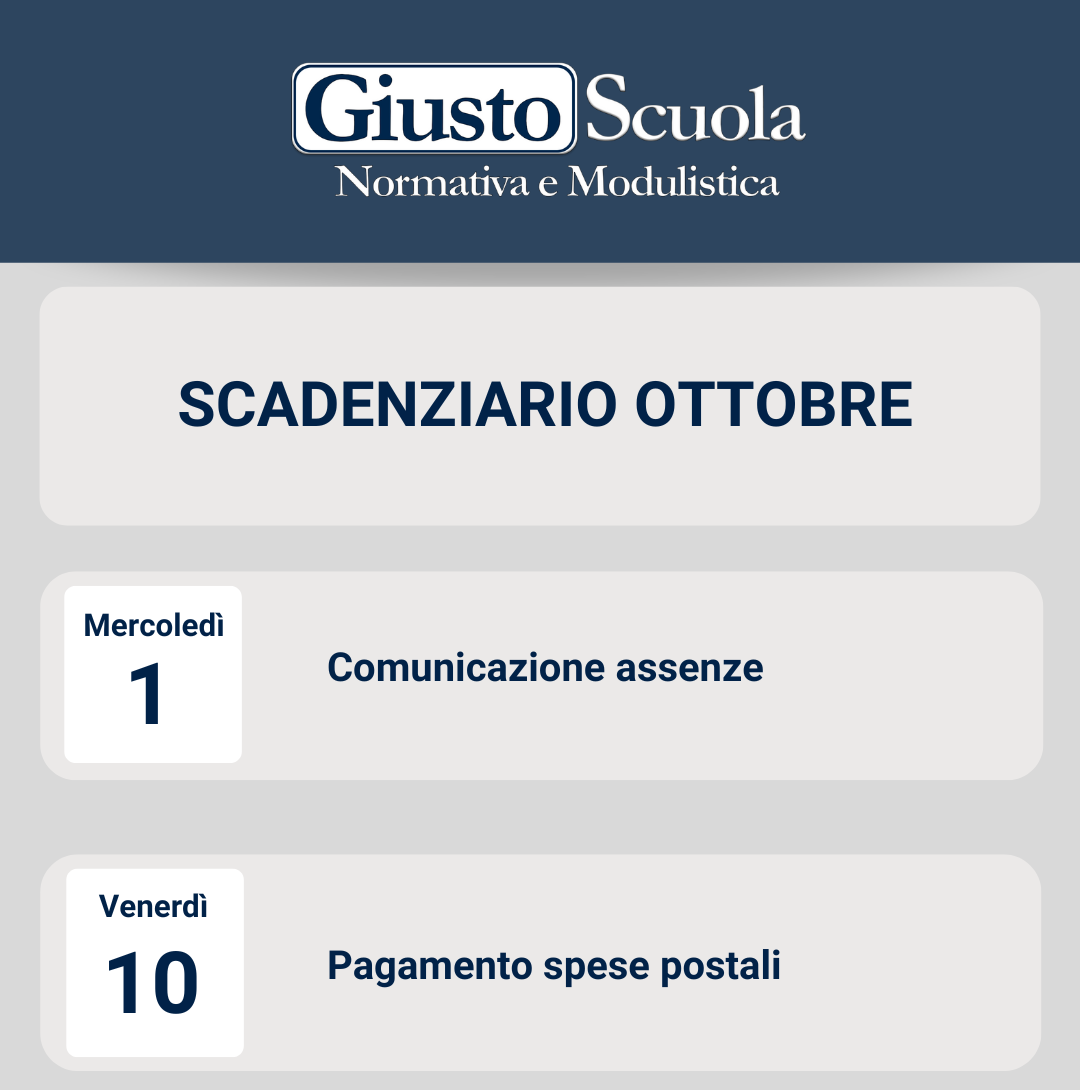La controversa questione sulla competenza del dirigente scolastico in materia di azione disciplinare nei confronti dei docenti.
di Francesco G. Nuzzaci, dirigente scolastico
1. Abbiamo avuto modo di prendere cognizione leggendo un autorevole commento su una recente ordinanza della Corte di cassazione in cui si prospetta un ripensamento dei giudici sul potere del dirigente scolastico di poter irrogare ai docenti anche sanzioni disciplinari sospensive dal servizio in coerenza con quanto stabilito dalla legge (1).
Siccome ci siamo soffermati spesso sull’argomento in generale e sul punto specifico in particolare (2), ci è sorto un naturale interesse ad approfondire il contenuto della predetta ordinanza, n. 10375 del 19 aprile 2025. Ma riteniamo metodologicamente più utile premettere l’antefatto; che ha visto prima la giurisprudenza di merito e poi quella di legittimità concordi nell’escludere il potere del dirigente scolastico di comminare ai docenti sanzioni disciplinari oltre la censura, e ciò nonostante l’opposto dato normativo primario (3).
L’iter argomentativo della richiamata giurisprudenza si può condensare nei passaggi che seguono:
a) Attese la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari, sulla scorta dei principi penalistici estensibili al più ampio diritto punitivo, per i docenti non può darsi luogo alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni, perché prevista – e laddove analiticamente prevista – solo per il personale ATA ai sensi dell’articolo 12 CCNL Scuola 2016/2018 (e ora replicato nell’articolo 24 del CCNL 2019/2021).
Sempre per i docenti, invece, il successivo articolo 29 (e anch’esso riprodotto nell’articolo 48 del CCNL 2019/2021) dispone che “continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs. 297/94”, che contemplano – dopo l’avvertimento scritto e la censura – la sanzione della “sospensione dall’insegnamento fino a un mese”; che non è ex litteris nella disponibilità del dirigente scolastico. Ciò in attesa di una specifica sessione negoziale a livello nazionale che definisca la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente ed educativo in armonia con l’avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro.
b) Il dirigente scolastico dovrà quindi, per la definizione della propria competenza, limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale massima irrogabile sulla base della disciplina figurante nell’ articolo 492, comma 2, lettera b) del menzionato decreto legislativo. E se ritiene che debba essere superiore alla censura, rimetterà gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
c) Secondo il principio di legalità e del correlato principio del giusto procedimento, non può dunque egli – contrariamente alle indicazioni della circolare esplicativa del MIUR n. 88/2010, susseguente all’emanazione del D. Lgs. 150/2009, Riforma Brunetta – scindere la fattispecie dell’articolo ultimo citato (Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese) qualora ravvisi, con una valutazione ex ante, che la sanzione da infliggere in concreto possa essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione dal servizio: dato che lo farebbe sulla base di “deduzioni meramente ipotetiche e discrezionali … incerte e opinabili, che ben potrebbero essere smentite all’esito del procedimento”.
E la novella recata dal D. Lgs. 75/2017 (Riforma Madia)non avrebbe modificato la disciplina sostanziale delle sanzioni, avendo solo ribadito per i dirigenti scolastici l’astratto potere di disporre direttamente la misura massima della sospensione dal servizio per non più di dieci giorni, con l’ulteriore specificazione –ricognitiva e non costitutiva – che essa concerne l’intero “personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario”; mentre è certo che questa prerogativa non sussiste più per tutti gli altri dirigenti pubblici, che devono ora limitarsi al solo rimprovero verbale e a segnalare al competente Ufficio per i procedimenti disciplinari i fatti stimati meritevoli di più gravi sanzioni.
2. Nell’ordinanza in discorso – n. 10375/2025 – la Cassazione si è pronunciata per la piena legittimità della sentenza con cui la Corte d’appello di Bari (n. 1805/2022), confermando la decisione del Tribunale del lavoro di Trani (sentenza n. 835 resa in data 13.05.2021), ha mandato esente da censure la sanzione disciplinare inflitta a un docente dalla dirigente scolastica e consistita nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per sei giorni, poiché “il comportamento del ricorrente … rientrava tra gli atti non conformi ai doveri ed alla correttezza inerenti la funzione docente, ai sensi dell’art. 494, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 297/1994”; e sanzione “proporzionata alla qualità e quantità delle violazioni contestate”.
Del pari correttamente – sempre per il giudice d’appello – lo stesso Tribunale di primo grado ha respinto, siccome inammissibile, l’eccezione di incompetenza della dirigente scolastica nell’irrogare la sanzione sospensiva, poiché sollevata dal docente solo in sede di deposito di note autorizzate e non emergendo tra i motivi di impugnazione della sanzione spiegati nel ricorso introduttivo del giudizio. Per poi proseguire che, ad “ogni buon conto”, quand’anche si volesse prescindere dalla tardività delle contestazioni formulate sul punto dall’appellante, “una definitiva chiarezza è stata fatta con il comma 9-quater, inserito nell’art. 55-bis D. Lgs. n. 165/2001 dalla cd. Riforma Madia (D. Lgs. n. 75 del 2017) e applicabile al caso di specie, con il quale si attribuisce al dirigente scolastico la competenza circa l’irrogazione di sanzioni disciplinari maggiori del richiamo verbale, fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni”.
Pertanto “l’univoco e chiaro tenore letterale delle disposizioni richiamate induce la Corte a ritenere che il procedimento disciplinare e la conseguente sanzione non sono, dunque, affette da alcuna nullità, non sussistendo la lamentata incompetenza dell’organo che ha irrogato il provvedimento di sospensione”.
Indubbiamente, nell’economia della statuizione della Corte d’appello di Bari, quanto testé riassunto può configurarsi alla stregua di un obiterdictum, fondandosi le ragioni decisorie del contenzioso sull’acclarata inammissibilità, in quanto tardivamente introdotta dal soggetto sanzionato, dell’eccezione di incompetenza della dirigente scolastica. E lo stesso dovrebbe dirsi per quel passaggio in cui la Corte di Cassazione riporta a latere la presa d’atto di quanto sentenziato dalla Corte territoriale in ordine alla “inammissibilità della eccezione di incompetenza dell’organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, siccome tardivamente proposta: eccezione che ha comunque ritenuta infondata nel merito(?), avuto riguardo alla competenza del dirigente scolastico in forza dell’art. 55 bis, comma 9 quater del D. Lgs. 165/2001, applicabile al caso in esame ex art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017”.
3. È certo che al momento non è dato di sapere se la Suprema magistratura di legittimità – qualora sollecitata – opererà un revirement della sua difforme giurisprudenza, che i giudici baresi non potevano non conoscere. Ma intanto ci pare che, nella circostanza, trovino conferma tutte le perplessità da noi espresse, sul punto, in precedenti interventi, dato che la predetta difforme giurisprudenza appare fondata su una falsa premessa: di equiparare, nella struttura e nella funzione, al diritto penale il diritto punitivo in genere e in particolare il diritto disciplinare, ovvero al processo penale il procedimento disciplinare.
Si sa che il diritto penale è preordinato alla difesa dei beni fondamentali e dei valori supremi della collettività, perciò dispiegando effetti totalizzanti sull’intera sfera giuridica dei soggetti che li abbiano violati, o messi in pericolo, una volta che la loro colpevolezza risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio. Ne derivano – oltre la tassatività delle fattispecie legali costituenti reato e il conseguente divieto di analogia – le ineludibili garanzie del giusto processo, che si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale precostituito per legge (articolo 111, Cost.).
Il procedimento disciplinare, per contro, è uno strumento di gestione del datore di lavoro: sia esso un soggetto privato o un’amministrazione pubblica, l’unica differenza essendo la facoltatività della sua attivazione nel primo caso e l’obbligatorietà nel secondo, qualora si sia in presenza di fatti stimati di rilevanza disciplinare e sempre nel rispetto delle procedure legali e pattizie per evitarsi abusi e per tutelare il lavoratore che si trova in una posizione di soggezione economica.
Esso pertiene dunque al potere direttivo nei confronti dei subordinati venuti meno ai loro doveri contrattuali ed è diretto a ristabilire, con immediatezza, il regolare svolgimento dell’attività lavorativa turbato dalle inadempienze e/o dalle trasgressioni del lavoratore, in tal modo ripristinandosi la posizione direttiva del datore di lavoro nell’organizzazione aziendale (Cassazione civile, sez. VI, 06.02.2015, n. 2330).
Certezza, immediatezza, effettività dello strumento disciplinare costituiscono il fondamento del D. Lgs. 150/09 e dei correttivi introdotti dal D. Lgs. 75/17 laddove, riscrivendo l’articolo 55-bisdel D. Lgs. 165/01 (“Forme e termini del procedimento disciplinare”), statuisce che “il mancato rispetto dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare … non determina la decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”, essendo perentori solo i termini per la contestazione dell’addebito (trenta gg. dalla piena conoscenza dei fatti) e per la conclusione del procedimento (centoventi gg. da detta contestazione). Ciò che è semplicemente, e giustamente, improponibile nel diritto penale, caratterizzato da un rigido formalismo e dal favor rei.
In altri termini, il legislatore ha inteso rinforzare le ragioni dell’azione disciplinare certa-immediata-effettiva; facente, per così dire ed entro certi limiti, premio sulle garanzie dei soggetti incisi: che ben troveranno – qualora la sanzione inflitta venga impugnata – la naturale loro difesa in sede giudiziaria (giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per i dipendenti pubblici contrattualizzati, TAR e Consiglio di Stato per quelli rimasti in regime di diritto pubblico), in cui sarà assicurata la piena applicazione delle regole del giusto processo.
E al riguardo – detto incidentalmente – appare invero privo di coerenza quel passaggio dell’ordinanza 28111/2019 (tra le tante), in cui la Corte di cassazione opera una scomposizione tra sanzioni disciplinari non gravi (avvertimento scritto e censura per i docenti, sino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni per il personale ATA) e gravi (le successive, sino al licenziamento ovvero alla sua versione pubblicistica della destituzione). Le prime – è scritto – sono legittimamente irrogabili dal dirigente datore di lavoro – che pure qui assomma gli stigmatizzati poteri istruttori, accusatori e decisori –, dovendosi privilegiare “il più veloce esercizio del potere disciplinare”; mentre per le seconde deve prevalere “l’esigenza di apprestare maggiori garanzie al lavoratore pubblico” mercé la specializzazione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e “soprattutto la sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, perché non coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare”.
Appare privo di coerenza, perché le esigenze di garanzia non possono essere discriminate ancorandole a meri parametri quantitativi, per sanzioni soggiacenti alla stessa procedura, che partecipano di un’unica natura, che importano i medesimi effetti (si veda l’articolo 12, commi 1 e 3 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.18, poi riprodotto nell’articolo 24 del successivo CCNL 2019/2021);
b) sempre lo stesso legislatore, con una sua libera valutazione politica, ha voluto rivedere il preesistente assetto normativo, stimando – a ragione o a torto – che certezza, immediatezza ed effettività delle sanzioni potessero meglio realizzarsi modificando il D. Lgs. 150/09 e affidando agli uffici per i procedimenti disciplinari il potere di comminare le sanzioni superiori al rimprovero verbale. Ma ha conservato, rinforzandola, e qui disattendendo il pregresso parere del Consiglio di Stato (Commissione speciale, parere dell’11.04.2007), l’eccezione per i dirigenti scolastici, in considerazione dell’alto numero delle scuole e dei dipendenti in ciascuna di esse, sì da ingolfare altrimenti i predetti uffici e derivandone sostanzialmente la non perseguibilità di gravi o reiterate negligenze in servizio, di violazione dei segreti d'ufficio e del pregiudizio al suo regolare funzionamento, dell'uso dell'impiego a fini d'interesse personale et alia: poiché con la misura massima della censura – ex art. 493, D. Lgs. 297/94 – potrebbero essere sanzionate solo una generica inosservanza degli obblighi di servizio e le non meno generiche condotte non conformi ai doveri verso i superiori, verso i colleghi e verso l’utenza;
c)l’eccezione prescritta dal legislatore per i solo dirigenti scolastici è dunque una scelta assistita da intrinseca ragionevolezza: requisito, quest’ultimo, che sembra invece difettare nel canone ermeneutico fino ad ora adottato dalla Cassazione, che abroga virtualmente una norma imperativa, la cui effettività è a tutt’oggi fatta dipendere dalla mera volizione delle organizzazioni sindacali del Comparto di dar seguito a una “specifica sessione negoziale”– che rimbalza da un CCNL all’altro – per la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché per l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte anti doverose dell’insegnante “e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà d’insegnamento”(!).
4. Una “specifica sessione negoziale” che non sarà avviata neanche in occasione del rinnovo del CCNL per il triennio – abbondantemente scaduto, come da deplorevole italica prassi – 2022/2024, avendo all’unisono le associazioni sindacali già dichiarato la totale indisponibilità a definire la materia qualora dovesse permanere il vincolo della legge Madia (id est: art. 55 bis, coma 9 quater del D. Lgs. 165/2001, come novellato dal D. Lgs. 75/2017), che assegna solo ai dirigenti scolastici, rispetto a tutti gli altri dirigenti pubblici, la competenza ad irrogare sanzioni disciplinari sospensive.
Dunque, non se ne farà nulla. Almeno fino a quando – e se– la Corte di cassazione non muterà la propria giurisprudenza, legittimando il dirigente scolastico a provvedere direttamente ad avviare l’azione disciplinare qualora, con una valutazione ex ante, preveda in concreto e con puntuale motivazioni che la sanzione da infliggere – qualora in esito al contraddittorio non si determini per l’archiviazione – possa essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio, diversamente dovendo egli rimettere gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Vale per il personale docente, ma anche per il personale ATA con riguardo alle fattispecie previste dal D. Lgs. 165/2001, richiamate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevedono sanzioni sospensive fino a un massimo di quindici giorni o da un minimo di tre giorni fino a un massimo di tre mesi o (anche di un solo giorno) fino a un massimo di tre mesi: all’occorrenza disapplicando – perché in contrasto con una norma di legge imperativa – quei passaggi che “in ogni caso” incardinano la competenza nell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
O non se ne farà nulla almeno sino a quando il Governo, in particolare il dipartimento della Funzione pubblica – lasciando perdere sessioni speciali o altri consimili diversivi paralizzanti – non solleciterà il legislatore ad emanare una legge di interpretazione autentica, nel senso poc’anzi indicato, ovvero a disegnare i connotati di una sanzione disciplinare tipica che preveda espressamente la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a dieci giorni anche per i docenti.
E fino a quando ciò non si verificherà o non sopraggiungano equivalenti superiori disposizioni, il dirigente scolastico dovrà, o almeno dovrebbe a scopo precauzionale e dopo aver compiuto una pre-istruttoria sulla loro rilevanza disciplinare, rimettere gli atti al competente Ufficio per i procedimenti disciplinari: se trattasi di docenti prefigurandosi astrattamente una sanzione superiore alla censura; se trattasi di personale ATA qualora si ritenga essere il limite oltre i dieci giorni di sospensione, ovvero versandosi nelle fattispecie del D. Lgs. e richiamate dal CCNL (sospensione fino a un massimo di quindici giorni, da un giorno a tre mesi, da tre giorni a tre mesi).
Note
- Marco Barone, C’è un ripensamento della Cassazione in tema di competenza del DS e sospensione disciplinare per il personale docente? in Orizzonte scuola, 3 maggio 2025;
- Rispettivamente e limitando i riferimenti all’ultimo quinquennio, si vedano: Il dirigente scolastico nel sistema delle sanzioni disciplinari, in Scienza dell’amministrazione scolastica, 1/2020; Le sanzioni disciplinari irrogabili dal dirigente scolastico, in Dirigere la scuola, 4/2020. Inoltre, La gestione del procedimento disciplinare nella scuola, in Amministrare la scuola, 7/2024.
- Già in vigenza dell’assetto statuito dal D. Lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta), antecedente del più esplicito D. Lgs. 75/2017 (cd. Riforma Madia, che ha riscritto il comma 9-quater, art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si è sviluppato un filone dei giudici di merito secondo cui il dirigente scolastico può ben comminare al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, per le fattispecie espressamente previste nel CCNL, ma non può andare oltre la censura nei confronti del personale docente.
Esso ha inizio con un’ordinanza collegiale del Tribunale di Ferrara del 30.10.2011, seguita dalle sentenze dei tribunali di Lagonegro (n. 19 del 16.01.2013), di Torino (n. 1434 del 03.06.2013), di Potenza (n. 590 del 04.10.2013), di Lodi, n. 252 del 03.11.2015, di Foggia, n. 7331/2016; e, in prosieguo, da quelle del Tribunale di Nuoro, n. 105 del 25.06.2016 e del Tribunale di Novara, n. 179 del 29.06. 2017. Poi recepito dalla Corte di cassazione con una serie di conformi ordinanze, tra le quali nn. 20845/2019, 28111/2019, 30226/2019, 23524/2021.